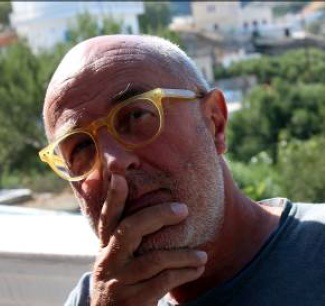Il
futuro si è deteriorato, sembra che non ci attenda niente di buono,
su questo sono tutti d'accordo, quando ero piccolo non era così: il
futuro aveva qualche problema ma complessivamente era radioso,
lucente, interplanetario, interstellare, intergalattico,
trans-spazio-temporale.
Per
Ivo Brandani, un soggetto residuale fuori dal ciclo
riproduttivo (un vecchio ingegnere di sessantanove anni), le
uniche dimensioni temporali possibili sono il passato e il presente.
L’intero
romanzo è giocato sull’alternanza tra questi due tempi narrativi.
L’arco di una giornata - il ventinove Maggio 2015 - è lo spazio
riservato alla disamina di una nauseante contemporaneità. I capitoli
sono scanditi dall’orologio: dalle 9:07 A.M a 7.47 P.M.
Un’interminabile giornata trascorsa con la debordante contrarietà
del protagonista. Ivo attende all’aeroporto di Sharm-el-Sheik il
volo di ritorno a casa. Si trova in Egitto per ricostruire con
materiali sintetici la barriera corallina. In questo speciale limbo,
l’unica dinamicità è offerta dalle sue associazioni mentali -
echi di Proust e di Celine - che generano un torrenziale monologo, un
feroce attacco al presente.
Il
presente che descrive Pecoraro è in realtà un futuro prossimo,
appena ad un anno di distanza dal nostro. Un anno che nel secolo
accelerato in cui viviamo può anche significarne dieci. I
riferimenti a questa realtà sono assoluti: le città sono indicate
come Citta di Dio (Roma) o Città di Mare. Con le maiuscole anche i
luoghi del potere, freddi, distanti: il
Governatorato, l'Amministrazione, i Distretti. I luoghi
decisionali sono lontani dall'individuo, vuoti. Tale descrizione
di una burocrazia spersonalizzante ricorda Saramago (il Centro nel
romanzo La Caverna, in particolare). E non è in ogni caso per niente
lontana dal senso di smarrimento, solitudine e inerzia che appartiene al
nostro tempo.
Il
fiume straboccante di parole contro la contemporaneità non è solo
il risultato dell’IMS (Irritable male syndrome anche conosciuto
come il ronzante rosicamento dei vecchiardi, a cui tutti noi siamo
abituati). Ma è una disamina acutissima della realtà coeva. Il
quadro è fosco.
Un
presente fasullo, vuoto e privo di bellezza. Il pianeta è ormai per
metà in decomposizione e per metà plastificato, popolato da
non-morti continuamente rigenerati dalle sostanze chimiche,
risollevati dalla chirurgia, sempre più lucidi, artificiali. La vita
ancora più lunga, quasi eterna, dove tutto è una copia di una copia
di una copia. Persino il cibo è assemblato artificialmente. Un fake
planet, devitalizzato ma in cui è quasi impossibile morire.
Anzi, si direbbe che morire sia faccenda d’altri tempi.
Stiamo
lentamente transitando dal naturale al post-naturale, una surrealtà
dove tutto è immagine di un originale scomparso.
E Ivo
- con il Rifacimento dei fondali marini in sintetico - contribuisce
alla ricostruzione di un mondo fantoccio, alterato, imitazione di una
realtà ormai perduta. Il tema della distruzione e della
ri-costruzione si intrecciano: Ivo fabbrica un mondo nuovo mentre
porta alla rovina quello vecchio, assume il doppio ruolo di homo
faber e homo destruens.
La
sua carriera di ingegnere strutturista infatti non l'ha portato a
progettare proprio un bel niente. Che contribuisca al disastro,
allora.
Io
sto al gioco, mi piace l'Apocalisse, mi ci trovo bene, ci godo...
I
toni apocalittici con cui viene descritta la contemporaneità
sanciscono il collasso del mondo in cui è cresciuto. L’ingegnere
si trova in una realtà dal volto irriconoscibile, da cui si sente
già scollato, lui e la sua mentalità novecentesca. Vorrebbe passare
gli ultimi stralci di tempo a sua disposizione assistendo ad un
grandioso disastro - qualcosa di veramente emozionante, finalmente -
è ossessionato dal senso della catastrofe. Non si inverte la
freccia del tempo , gli direi a questi qui dietro il banco. Tutto
deve andare a male, marcire, degradarsi, rovinarsi, fottersi
definitivamente. Ma non ci sarà nessuna esplosione, solo un
lento deteriorarsi che cambierà il volto del mondo. E Ivo si si
sente già prossimo alla fine. Come i soldati che muoiono
l’ultimo giorno di guerra, come a quei bambini che presero la
poliomielite quando il vaccino era già in distribuzione. Sulla
soglia di una nuova era.
A
queste amare invettive, si alternano capitoli dedicati alle
reminiscenze del suo passato. Sgorgano dalla mente di Ivo ricordi a
ritroso, da quelli più recenti all’infanzia, fino ad un finale
fuori dal tempo. Dunque mentre la giornata del ventinove Maggio
procede in senso orario - dalla mattina alla sera - il passato di Ivo
si ripropone in senso antiorario, dalla vecchiaia alla sua nascita.
La narrazione procede perfettamente su questi due binari
temporali, alternando questi due ritmi. La struttura del romanzo
fa sì che la fine di Ivo - sappiamo dal primo capitolo cosa lo
ucciderà - coincida con l’inizio della sua vita. Un motivo
circolare che si ripresenta costantemente: il viaggio di ritorno
dall’Egitto, il ritorno con la mente alla casa d’infanzia, al
nucleo familiare d’origine e soprattutto al padre, paradigma
tirannico e irrefutabile.
Se
inoltre il 2015 aveva caratteristiche vaghe, un contesto
futuristico, il passato di Ivo al contrario ripercorre la Storia
d'Italia. Un contesto a noi familiare, che viene però riletto con
una nuova chiave da Pecoraro.
Queste
immersioni nel passato - alcune rappresentano dei perfetti racconti
autoconclusivi - danno una giustificazione al cinismo dell’attuale
Brandani. Il suo vissuto è segnato dall’inadeguatezza e dai
fallimenti. La vita lo ha attraversato, e lui l’ha subita.
EFFETTO
CORIOLIS: ogni traiettoria subisce una curvatura, talvolta fino ad
avvitarsi su se stessa...Non sei mai dove avresti voluto essere, non
arrivi mai nel punto dove hai messo la prua, ma sempre da qualche
altra parte e ti dice bene se riesci a finire nei pressi del tuo
obiettivo...Io, ammesso che avessi un obiettivo, non solo l'ho
mancato in pieno, ma da qui nemmeno lo vedo più
La
vita di Ivo scorre in tempo di Pace ma in realtà è un susseguirsi
di conflitti meschini da cui uscirà sempre sconfitto.
Il
conflitto Originario è quello con il Padre, figura ostile e
fascista, fedele a due unici Valori: Coraggio e Orgoglio. Due qualità
che sfortunatamente Ivo sembra non avere. Padre costruisce per lui un
mondo non-alla sua altezza, di fatto castrandolo e rendendolo un
inadeguato-a-vita. Ivo così chiuso nel suo invernale voler
restar dentro è spinto a forza fuori. Un fuori barbarico
e primitivo: il mondo dei ragazzini, in cui si riproducono le
dinamiche sociali della prevaricazione e della violenza. Ivo è
persino una pippa a giocare a calcio, qualità invalidante.
Nonostante il dopoguerra, il boom economico e l’ottimismo degli
anni Cinquanta, il microcosmo della Città di Dio nasconde una realtà
vile e brutale. La lotta sociale è spietata, l’unico modo
per galleggiare è menare. Farsi riconoscere come
uno che mena garantisce lo status di dominante.
La
giovinezza di Ivo squarcia subito qualsiasi illusione. Il grande Male
della Pace è la lotta per emergere, per imporsi sugli altri. Un
conflitto eterno. Il Tempo di pace è la lotta di tutti
contro tutti, la violenza è del tutto privata, egoistica.
Non c’è una guerra - e quindi una violenza imposta, obbligata -
che ti costringa a definirti secondo valori civili condivisi come
quelli di Patria o che ti spinga a fare i conti con la sopravvivenza,
con la parte più intima di te stesso. L’alternativa vertiginosa
tra vita o morte non esiste nel tempo di Pace. La Pace ti
cuoce lentamente ti culla con antidepressivi, ansiolitici e
ti confonde, ti istupidisce, ti isola.
In
questo caos in cui Ivo fatica ad imporre la sua individualità (se lo
ripete sempre:Brandani tu non sei un combattente, non sei un
competitore…) il protagonista cerca un ordine alternativo
alla crudeltà del comandamento homo homini lupus. Tenta con la
rigidità del Pensiero: si iscrive alla facoltà di Filosofia. è
coinvolto nelle lotte del 68’ e gli basta poco per capire che
qualsiasi gruppo -persino quelli che propugnano idee di uguaglianza e
di fraternità - nascondono la stessa ossatura, naturale negli
uomini, gli stessi meccanismi di dominanza e sottomissione, lo
stesso gregarismo.
E
d’altronde Ivo capisce di essere inadatto alla lotta politica,
qualsiasi scenario di battaglia lo atterrisce.
Sono
un non-eroe, un non-coraggioso, un non-dominante, uno che non ci
crede, che non crede a niente, che non ha mai creduto a niente…sono
uno-che-molla, uno che per lui niente conta, se non restare in vita
nelle migliori condizioni possibili
Durante
un viaggio in Inghilterra, si trova davanti al Firth of Fourt Bridge.
Ha un’illuminazione.
Se la
Natura lo ha tradito, se è inadatto a qualsiasi contesto di
selezione naturale - e quindi inevitabilmente di prevaricazione
fascista e violenta - allora, la Scienza, la costruzione, possono
essere usate contro la Natura. La filosofia non aveva portato ordine,
non aveva dato un Senso ma soprattutto non aveva dato un risultato
visibile. La Scienza, al contrario, opponendosi ai diktat naturali
permette di unire ciò che è separato, può creare dei ponti.
A
seguito dell’epifania, abbandona la facoltà di Filosofia (ma non
gli Ideali di sinistra, per quello c’è tempo) e si iscrive ad
Ingegneria. Finalmente, eliminata la variabile umana, Brandani ha
un mestiere.
Il
mondo del lavoro si rivelerà ancora più mortificante di quello
adolescenziale e universitario. Non ci si fa la guerra né con le
bombe né con i cazzotti come nel quartiere, ma con mezzi assai più
subdoli. Il suo capo De Klerk è un manager di successo, aderisce al
mondo così com’è e non come dovrebbe essere, al contario di Ivo
ancora ancorato alla chimera dell'idealità. Questo capitolo è un
piccolo capolavoro di narrativa: Pecoraro fornisce attraverso il
racconto di un viaggio in barca una perfetta allegoria della
fortissima pressione che esercita il capitalismo su di noi. De Klerk
è tutto ciò che Ivo odia: maschilista, predatore, tirannico, un
dominante. Brandani coltiva infatti nei confronti della mentalità
borghese e materialista - tutto ciò che De Klerk rappresenta - un
retro pensiero infantile: non mi avrete mai. Eppure De
Klerk è più forte di lui, il suo modello prima lo affascina, poi lo
avvince e infine lo schiaccia. Ivo non può niente.
Di
fatto ti collocasti nella grande Catena dei Sì. (...)Ti consegnerai
nelle mani del capitale, sarai un ingranaggio del profitto.
La
sua blanda riserva mentale - “non mi avrete mai” - è una vana
resistenza. Tutto è dentro la logica di mercato, senza scampo.
Sembra di leggere le pagine profetiche di Cosmopolis (di Don
DeLillo): “non esiste niente fuori dal mercato”.
La
Grande Classe Media Uniforme dell'Occidente Democratico, quella che
ha divorato e inglobato in sé tutte le altre classi, compresa quella
operaia, dedita alla ragione passiva. I nativi del capitalismo
mediatico non conoscono la nozione di opposizione, di alternativa.
Ha
ragione Cortellessa quando parla di Pecoraro come scrittore di
guerra. La guerra dei “sessant’anni di pace, nei tanti inferni
del fare umano”. è questa la grande forza del romanzo: la sua
potenza demistificatrice, il pessimismo lucido, la coscienza della
complicità e della colpa. Ma anche la rassegnazione al caos
dell'esistenza, alla non forma delle cose. Come
pretendiamo che ci sia ordine se viviamo, anzi, siamo ciò che resta
di un'esplosione?
Il
delirio lucido di Brandani sgorga fuori con aggressività, una lingua
corrosiva, senza tabù. Seguendo gli stilemi del modernismo, Pecoraro
redige un romanzo verboso - come gli anziani Brandani è
puntiglioso, si ripete senza sensi di colpa - contaminato da nozioni
scientifiche, architettoniche, storiche, biologiche. Il suo è
un epos rovesciato, senza eroismi né imprese. Può darsi
che La vita in tempo di pace sia la perfetta
anti-epica, l’uomo senza qualità del nostro Tempo.
Indubbio
è che questo romanzo per gli scrittori italiani rappresenti - già -
una tappa obbligata.
“Niente
tornerà più, nessuna promessa è stata mantenuta: Dio non c'era, il
mondo non ti stava aspettando, nessuno ti cercava, di là dal mare ci
sono solo altri ristoranti di fritto misto e il mestiere, che
prometteva, alla fine si è negato. O forse tu eri negato per farlo
bene, Ivo...”.